Description
1. Porta di Juso, la Dogana della Città aragonese fra Principato e Capitanata
Il toponimo “Juso” fa venire alla mente Riccardo Filangieri, signore, nella seconda metà del 1400, di Capri di Suso e Capri di Juso. Per avvicinarci all’antica provincia aragonese di Capitanata, diremmo che in Puglia, a Ceglie Messapica, esisteva una Porta di Juso, così come la chiamavano i frati del convento di San Domenico. “Juso” deriverebbe quindi dall’avverbio di luogo “giuso”, cioè “giù”, sotto, in uso fra il 1200 e il 1500, dal tardo latino “Jusum e Josum” con il significato di volgere, propriamente volgere in basso.1
Termine rinvenuto anche a Pietrastornina, dominio dei Carafa al tempo degli Aragonesi, per indicare la Chiesa di Santa Maria di Sotto con il termine di S.Maria de Juso, come anche si usava per indicare le Chiese di S.Maria della Porta di Juso.
Juso fu una delle porte di Atripalda. La notizia viene fuori dal Catasto Onciario. Era la porta che si trovava nella parte più bassa del borgo, immaginando che un tempo ve ne sia stata almeno un’altra, quella di Suso. Una porta di “su” e una porta di giù” che non andrebbero confuse con una eventuale Porta della Dogana, a meno che la riscossione del dazio non avvenisse esattamente alla Porta di Juso che quindi sarebbe stata anche la Porta della Dogana.
Ad ogni modo, Atripalda, proprio nel periodo aragonese, sarebbe stato il primo feudo del Principato Ultra, venendo dalla Puglia, lasciata la Capitanata. Ma questi inusuali elementi lascerebbero pensare addirittura che il Principato finisse ad Avellino e che la Dogana di Atripalda non sia stata altro che la Dogana del Viceregno aragonese di Puglia ricadente nella sottoprovincia pugliese di Capitanata. E’ emblematico che gli Agostiniani, nell’ubicare il loro monastero atripaldese affidato agli Osservanti, lo indicheranno come in area “del Pugliese”, elencandolo nel loro dizionario, al numero 491: Atripalda (1620-1866), dopo quello di Cerchio e Nereto, e prima di Castelluccio, Corsano, Deliceto, Montefalcone e Tufara.
Più di una volta, Galante Colucci, ha ricordato agli atripaldesi dell’antica ubicazione ella vecchia Dogana, “Sott ‘a ruana”, distinguendola da quella nuova nata intorno al 1806, e dall’altro quartiere della città divisa dal sabato, chiamato “Fore ‘o mercato”. Atripalda è stata quindi una cittadella di solo due borghi, fra Dogana e Mercato, almeno intorno al 1700. Nel quartiere della Dogana partiva la via dove gravitavano tre chiese: Sant’Ippolisto (Chiesa Madre), Santa Maria e San Giovanni, mentre in fondo all’area verano l’Annunziata con l’Ospedale dei poveri camminanti, da dove si apriva la via delle due Ferriere, per la lavorazione del ferro. La Dogana, da cui si aprivano le arcate e l’ingresso per l’accesso dei carri, non era altro che un deposito di cereali provenienti dalla Puglia, che venivano sfarinati nei numerosi mulini disseminati lungo la Valle del Sabato fino a Pratola Serra, prima di essere dirottata a Napoli. Galante dice il giusto. Ma nessuno aggiunge che fu la Dogana di Atripalda a far scoppriare la guerra fra Francesi e Spagnoli nel 1501. O meglio la linea di confine fra il Principato e la Capitanata. Per comprendere meglio cosa avvenne dovremmo ricordare che gli Aragonesi avevano diviso il Regno di Napoli in sei Viceregni, cioè 6 province. Fu infatti, come scriveva il Guicciardini nella sua Storia d’Italia, dai tempi di Alfonso di Aragona “primo re di Napoli di quel nome, il quale, avendo rispetto a facilitare le esazioni delle entrate, divise tutto il reame in sei provincie principali, cioè in Terra di Lavoro, Principato, Basilicata, Calavria, Puglia e Abruzzi”.
Gli Aragonesi avevano anche diviso alcuni di questi Viceregni di provincia in diverse ripartizioni circoscrizionali. Lo stesso Guicciardini ricordava che “La Puglia era divisa in tre parti, cioè in Terra di Otranto, Terra di Bari e Capitanato”, con il Capitanato, da tempo immemore, nelle mani degli Orsini.
Già nell’aprile del 1496, alle prime avvisaglie di guerra fra i capitani di ventura, il nome di Atripalda era venuto fuori allorquando fu presa di mira da Ivo di Allègre. Questo capitano francese, dopo la sconfitta subita dagli Spagnoli a Cerignola, si diresse da Venosa verso Atripalda inseguito da Pietro di Paz e Teodoro Boccali, il quale verrà catturato con Diego di Vera e l’Escalada nel corso di una scorreria. Fu poi in breve tempo liberato, come spesso accadeva, per uno scambio di prigionieri.
Nel 1500, Atripalda, continuava ad essere il baricentro per la riscossione del dazio non solo sul grano, ma anche sulle pecore che dalla Puglia, raggirando l’Appia beneventana essendo la città nelle mani del Vaticano, venivano fatte transitare sul diverticolo di Atripalda perchè dirette a Napoli, per essere macellate e lavorate, come ricorda Lucio Fiore.
Le sei province dei Viceregni aragonesi, con l’occupazione di Francesi e Spagnoli nel 1501, subirono uno smembramento a causa della divisione del territorio fra le due nuove potenze.
Francesco Guicciardini (1483-1540), nella sua Storia d’Italia (Libro V, Cap.7), pone fra le cause di discordia che diedero inizio alla guerra fra i Francesi e gli Spagnoli per il possesso del Regno di Napoli la riscossione del dazio sul transito delle pecore dall’Abruzzo in Puglia o dalla Puglia nel Principato.
Presumibilmente il riferimento è proprio alla Dogana di Atripalda (1501), fino ad allora confine aragonese della ripartizione della Capitanata del Viceregno di Puglia.
Le discordie fra i capitani francesi e spagnoli erano nate nell’anno precedente (1500) ed avevano avuto origine dopo “la divisione fatta tra i due Re aggiudicata all’uno la Terra di Lavoro e l’Abruzzi all’altro”.
Quell’accordo, infatti, non decise la linea di confine del territorio fra la Puglia e la Calabria, in quanto “non furono espressi bene nella divisione i confini e i limiti delle provincie, donde ciascuno cominciò a pretendere che a sè appartenesse quella parte che è detta il Capitanato”.
Il motivo del contendere fu quindi l’annessione della Capitanata: i Francesi la volevano in Terra di Lavoro, gli Spagnoli in Calabria, “dando occasione a questa disputazione l’essere stata variata la denominazione antica delle provincie da Alfonso di Aragona”.
Il Capitanato era “contiguo all’Abruzzi, e diviso dal resto della Puglia dal fiume di Lofanto già detto Aufido”.
Sarebbe quindi rientrato più in Abruzzo, il Capitanato, a dire dei Francesi o al massimo in nessuna delle quattro province divise. Ma il Capitanato, oltre il foggiano, seguento l’Ofanto, partendo da Cerignola, comprendeva l’Alta Irpinia da Monteverde e Calitri a Sant’Angelo dei Lombardi e Lioni, città queste, che gli Spagnoli intendevano continuare a tenere unite alla Puglia.
“Pretendevano i Franzesi (i quali non avendo in considerazione la denominazione moderna avevano, nel dividere, avuto rispetto alla antica) o che il Capitanato non si comprendesse sotto alcuna delle quattro provincie divise o che più tosto fusse parte dell’Abruzzi che della Puglia; movendogli non tanto quello che in sè importasse il paese quanto perchè, non possedendo il Capitanato, non apparteneva a loro parte alcuna dell’entrate della dogana delle pecore, membro importante dell’entrate del regno, e perchè, essendo privato l’Abruzzi e Terra di Lavoro de’ frumenti che nascono nel Capitanato, potevano ne’ tempi sterili esserne facilmente quelle provincie ridotte in grandissima estremità, qualunque volta dagli spagnuoli fusse proibito loro il trarne della Puglia e della Sicilia”.
Al contrario, gli Spagnoli, facevano notare che non poteva “il Capitanato appartenere a’ Franzesi, perchè l’Abruzzi terminato ne’ luoghi alti non si distende nelle pianure, e perchè nelle differenze de’ nomi e de’ confini delle provincie si attende sempre all’uso presente. Sopra la quale altercazione erano stati contenti, l’anno dinanzi, di partire in parti eguali l’entrata della dogana; ma il seguente anno, non contenti alla medesima divisione, ne aveva ciascuno occupato il più che aveva potuto. E si erano aggiunte poi nuove contenzioni, nutricate insino allora (così era la fama) più per volonta de’ capitani che per consentimento de’ re”. In realtà, gli Spagnoli “pretendevano che il Principato e Basilicata si includesse in Calavria, che si divide in due parti, Calavria citra e Calavria ultra cioè l’una di sopra l’altra di sotto, e che Val di Benevento che tenevano i franzesi fusse parte di Puglia”.
Per questo motivo, gli Spagnoli, “mandorono ufficiali a tenere la giustizia alla Tripalda vicina a due miglia ad Avellino, ove dimoravano gli ufficiali de’ Franzesi” al fine di far valere le proprie idee. Principii spagnoli che andavano contro quelli dei Signori locali, i quali, erano anche in “dissensione”, ritenendosi molestati essendo i “baroni principali del regno”. Principii sbagliati che finirono con l’intromettersi nella politica antagonista di “Consalvo Ernandes e Luigi d’Ormignacca duca di Nemors vicerè del re di Francia”. Fu a causa dell’invasione spagnola delle Terre lungo il Sabato che i due capi di Spagna e Francia in Italia si spostarono verso il confine: il Vicerè francese di Napoli si portò a Melfi e il luogotenente spagnolo Consalvo occupò Atella, terra del principe di Melfi, sfidando l’alleato ma al fine di chiarire i confini. Dopo “pratiche di qualche mese, nelle quali anche i due capitani parlorno insieme, non trovandosi tra loro forma di concordia, convennono aspettare la determinazione de’ loro Re, e che in questo mezzo non si innovasse cosa alcuna”. Ruppe la tregua il vicerè francese di Napoli, il quale, “insuperbito perchè era molto superiore di forze, avendo pochi dì poi fatta altra deliberazione, protestò la guerra a Consalvo in caso non rilasciasse subito il Capitanato, e dipoi immediate fece correre le genti sue alla Tripalda”.
Nel 1501 Atripalda fu occupata dai Francesi, “dalla quale incursione, che fu fatta il decimonono dì del mese di giugno, ebbe principio la guerra: la quale continuamente proseguendo, cominciò senza rispetto a occupare per forza, nel Capitanato e altrove, le terre che si tenevano per gli Spagnuoli”.
Consalvo attese notizie da Madrid e pagò i Sanseverino, padroni di mezzo Regno, affinchè passassero dalla sua parte.
Il Vicerè francese cominciò quindi a togliere paesi pugliesi dalle mani degli Spagnoli, “le quali cose non solamente non furono emendate dal suo Re ma, avendo già notizia che il Re di Spagna era determinato a non gli cedere il Capitanato, voltato con tutto l’animo alla guerra, gli mandò in soccorso per mare dumila svizzeri, e fece condurre agli stipendi suoi i prìncipi di Salerno e di Bisignano e alcuni altri de’ principali baroni”.
Al Re di Francia non restava che decidere di trattare con il Re di Spagna l’ottenimento dell’intero ex Regno di Napoli. Infatti, dopo di ciò, si portò a Lione al fine di “fare le provisioni necessarie all’acquisto di tutto il reame, al quale, non contento de’ luoghi della differenza, già manifestamente aspirava, e con intenzione di passare, se bisognasse, in Italia”.2
Questo accadeva quando Lautrec ancora non aveva invaso l’ex Regno di Napoli e nell’imboscata di Atripalda avevano già perso la vita 200 uomini di entrambi gli schieramenti di Aubigny, Giannotto Francese e Giovanni Loigno contro Gorrier.
Atripalda tonò a farsi sentire nella storia legando il nome della città al suo nuovo padrone, Alfonso Granai Castriota, che ricevette il titolo di Marchese dal 1513. Questi, scoppiata nel 1521 scoppiò la prima guerra di successione tra l’imperatore di Spagna, Carlo V, e il re di Francia, Francesco I, alleato di papa Clemente VII.
Il conte di Atripalda, Alfonso Castriota, si diresse sulle coste pugliesi nelle mani degli alleati veneziani, per fronteggiare l’esercito francese al comando di Gabriele Barone, ingaggiando anche cinquecento lance albanesi, risuscendo a liberare le Terre di Bari e la Terra d’Otranto occupate dal nemico e donandole poi a Carlo V, in cambio di ricchezze e titoli nobiliari. Le truppe Gallipolitane di Carlo V, furono quindi comandate da Don Filippo Castriota e Don Pedro (zio e nipote), i quali, all’arrivo di Lautrec nel tarantino, sconfissero in battaglia (1528), Fracensco Del Balzo, costringendolo all’esilio. In questo periodo c’è da ricordare la figura del Signore di Ottaviano Fabrizio Maramaldo o Maramao (1492-1552), il quale, entrato nel Regno di Napoli per liberarlo dai Francesi, assediò Rocca d’Evandro obbligando alla resa l’abate di Montecassino, Crisostomo d’Alessandro, fra l’altro suo parente e, accampatosi ad Aversa con 1600 fanti, ebbe l’ordine dal Principe d’Orange di portarsi a Troia. Fu allora che i suoi soldati, calabresi e lucani, decisero di non continuare solo dopo aver ricevuto gli stipendi, che non ebbero, ripartendo verso la Puglia, ottenendo in pegno una mitria papale del tesoro di San Pietro.
Da Castel di Sangro, con Sciarra Colonna e l’Orange alla testa di 3000 fanti, nel marzo del 1528, a capo di 1600 fanti, Maramaldo marciò su Atripalda con le milizie di Ugo di Moncada. Questo trionfale passaggio venne ricordato perchè il comandante conduceva 14 bandiere di fanti tutti ai suoi ordini. Fece poi tappa su Napoli dov’era asserragliato Lautrec.
L’accoglienza delle truppe spagnole evitò ad Atripalda il saccheggio, per far fronte agli stipendi dei militari, che invece toccò ad altri comuni del Nolano. Questo episodio particolare, infatti, accadde il 21 marzo, quando gli Spagnoli scelsero la via della fuga al comando del principe d’Orange, il quale ordinò a Sergianni Caracciolo, principe di Melfi, alla guida di due compagnie di spagnoli e due di italiani, di fermarsi in Melfi e trattenere il nemico, dirigendosi di nascosto verso Napoli. “L’Orange guidava i Tedeschi, il Gonzaga la cavalleria, il Guasto gli Spagnoli”. Da qui, saccheggiata Ariano perché si era data ai Francesi, passò per Atripalda dove si unì il Principe di Salerno e il Maramaldo, e marciarono verso Napoli passando per Montefusco ed Avellino, in direzione di Nola dove avvenne il saccheggio della città per pagare il salario ai soldati. “Si levarono per forza le robe dalle case con molte ingiurie e bastonate. Raccolto le vettovaglie si diresse a Napoli. Erano forzati i padroni di carreggiare ogni cosa in Napoli con buoi e animali. La gente era sconvolta. Non si sentiva altro per le terre che bandi, ordini, carreggi e violenze”.3
5. Fabbriche di rame e lana e omicidi facili ai tempi dei Principi Caracciolo
Don Alfonso Granai Castriota, Marchese di Atripalda, continuò a farsi valere fino alla morte (+1544), dopo di cui, nel 1564 il feudo passò ai Caracciolo, nominati Principi di Avellino e Duchi di Atripalda nel 1572. Furono i Caracciolo a costruire, sopra Capo la Torre, il grande Palazzo-castello che dominava la città.
Sotto i Caracciolo Atripalda mantenne l’autonomia di sempre legata alla dogana, ma acquisì anche quella ecclesiastica e un certo rinvigorimento dovuto alla costruzione della Regia Strada delle Puglie. Rifiorirono mulini e ferriere, a cui si affiancarono gli opifici per la lavorazione delle ramiere di rame e della carta, che utilizzavano la forza delle acque del fiume Sabato, seguita da quella della lavorazione della lana.
Queste industrie permisero una forte ripresa del commercio che fiorì anche grazie alla presenza del mercato dove venivano a vedere e comprare i mercanti pugliesi. Non sempre però, durante i mercati, si poteva avere garantita la sicurezza. Anzi, si rischiava di essere accusati di assassinio e condannati dal Tribunale di Montefusco solo per sospetto, come accadde nel 1633 a Melillo, il quale sarebbe finito impiccato se non fosse stato per l’avvocato Eliseo Danza. Questa la storia. “Un tipo chiamato Molinaro fu visto da molti nel mercato, ma non fece ritorno a casa sua nè di lui si seppero più notizie. Ma si sparse la voce che era stato ucciso mentre da Atripalda ritornava a Summonte. Pertanto Pietro Antonio Molinaro, suo fratello, e Clementina Melillo, sua moglie, vennero in questo regio tribunale e sporsero querela per detto omicidio e indicarono come sospetto tale Angelo Pacillo della Terra di Capriglia. Il loro sospetto si fondava su due motivi, primo perchè il detto Pacillo aveva chiesto in moglie Angelina Melillo, cognata dell’ucciso, ma questi si era adoperato per mandare a monte il matrimonio per disparità di condizione, secondo perchè il Pacillo era stato estromesso dall’affitto di una masseria per la quale Gian Domenico Molinaro aveva fatto una offerta più vantaggiosa al proprietario. Per tali motivi i due erano divenuti nemici. Fu nominato un commissario della causa il quale nell’istruttoria raccolse le prove della partenza da casa del Molinaro, del suo non avvenuto ritorno ad essa, della sua inimicizia col Melillo nonchè di alcune minacce contro di lui dal Melillo in più di una occasione pronunziate. Si presentarono inoltre alcuni testimoni i quali asserirono d’aver sentito dire da alcuni viaticali di Lauro di aver visto detto Gian Domenico Molinaro morto, disteso per terra in un bosco presso Atripalda. Ma poichè il cadavere non fu trovato in quel posto, i testimoni insinuarono che era stato asportato dall’omicida aiutato da un suo fratello. Ma il cadavere non fu trovato in nessun posto. Questo delitto sembrò a tutti troppo spietato e degno di rigorosa pena. Per tanto il Melillo fu arrestato e incarcerato, e il Fiscale a gran voce andava dicendo: sia impiccato, sia impiccato!”.
Così il Danza: “Io che ero stato scelto come avvocato difensore dell’imputato mi opposi fortemente al Fiscale”, il Pubblico Ministero, “dicendo che senza trovare il corpo del reato, cioè senza il cadavere dell’ucciso, non si poteva nemmeno indire la celebrazione del processo. Nei delitti di omicidio infatti non bastano le congetture e gl’indizi e nemmeno la stessa confessione dell’imputato, bisogna trovare il cadavere dell’ucciso. Il Fiscale però, respinte le mie ragioni, richiedeva l’immediata celebrazione del processo e l’esemplare punizione dello imputato, dicendosi pago degli indizi accertati. Mi sembrò che i Giudici non fossero alieni dalle tesi sostenute dal Fiscale. Già vedevo il mio cliente pendere dalla forca. Allora, per prendere tempo, sollevai un incidente procedurale chiedendo che la causa fosse rimessa alla Curia del Barone di Capriglia, patria dell’imputato. Si cominciòn allora a discutere sulla mia richiesta ma mentre noi nella Curia furiosamente discutevamo, Gian Domenico Molinaro, il presunto morto, ricomparve nel suo paese vivo, libero, illeso e sano. Disse che in quel giorno, quando andò ad Atripalda, aveva trovato nel mercato un suo antico padrone della Città di Venosa col quale se n’era andato in Puglia dov’era rimasto per tutto il tempo della sua assenza dal paese. Mi sia lecito dare un consiglio ai Giudici: nei delitti di omicidio guardatevi, come dal fuoco, dal prestar fede ai testimoni e dal dare troppo peso agli indizi, per prima cosa trovate il cadavere”.4
L’occupazione austrica segnò per Atripalda un’altra marcia in avanti. Il suo Duca e Principe di Avellino Francesco Maria Caracciolo fu uomo di vita e di potere, uno dei più potenti amici dell’Imperatore d’Austria. Durante la permanenza a Napoli, oltre a collezionare privilegi, si diede ai grandi amori.
Rosa La Palermitana, una graziosa puttanella siciliana, abitava alle spalle di Via Toledo. Giunta nella capitale, aveva conquistato le simpatie del Principe dal primo appuntamento serale. Con lei il Caracciolo spandeva e spendeva, riempiendola di doni anche se continuava a professare il mestiere più antico del mondo. Ma fu con lui che si era arricchita. Da qui la decisione di lasciarla, essendo ormai la cosa di dominio pubblico. Un giorno, ripassando per via Toledo con un cavaliere, Rosa lo fece ingelosire regalando al compagno di strada e non a lui il fiore che teneva in mano. Se ne sarebbe pentita amaramente. Com’era possibile che un principe potesse essere insultato da una sgualtrina?
“Me la pagherai!”, minacciò a voce alta il Principe. Tornato a palazzo informò dell’accaduto l’armiggero che teneva a servizio. Francesco, detto Galluzzo, era un bandito di nazionalità siciliana assoldato a Palermo come guardaporte e fido sicario. A lui il Principe si rivolse imponendogli di vendicarlo in cambio di una forte somma di danaro. Gli promise inoltre la grazia se fosse stato scoperto e di aiutarlo in ogni necessità. Avuta la certezza che sarebbe stato servito di lì a pochi giorni, già pregustava la vendetta per l’affronto subito. Il 10 agosto del 1723 il Galluzzo, fingendosi emigrante, si presentò a casa di Rosa, che già aveva conosciuto per fama a Palermo, dove ella conviveva con la madre. Le chiese di stare a letto con lei per una notte, in cambio di un buon regalo. Avuto l’assenso si presentò a cena con un altro armiggero guardaporte. I due scannarono lui e la madre verso le sei o le sette del mattino presto, scappando di fretta e furia al punto di lasciare un candelabro d’argento in cima alla scala e portandosi via solo l’anello sfilato dal dito del cadavere di Rosa. Qualche tempo dopo, durante una partita di fronte a Castelnuovo, accecato dal gioco, Galluzzo rimase senza quattrini. Incurante del rischio che correva, offrì in pegno proprio quell’anello visto da troppi clienti.
Scoperto e riconosciuto colpevole del duplice delitto fu imprigionato nel carcere di Ponte di Tappia. Reo confesso anche di altri reati, dimentico della promessa, coinvolse il Principe. Nonostante gli sforzi del Caracciolo per salvarlo, essendo anche cancelliere, perse la causa, tenutasi di fronte alla Corte Suprema di Vienna. Il verdetto fu durissimo: morte per il Galluzzo ed esilio perpetuo per il Principe, previo esborso di un’ingente somma, riconosciuto colpevole di quello e di altri delitti. L’8 ottobre il Vicerè ordinò l’impiccaggione del Galluzzo accusato di omicidio su mandato.
Non è escluso che le cronache del tempo abbiano esagerato, ma il Principe Caracciolo non fu uno stinco di santo. Durante uno dei suoi viaggi a Venezia venne a duello con un gioielliere perchè amavano entrambi la figlia di una locandiera. Lo spedì dritto all’inferno. Fatto che creò forti contrasti con il Vicerè napoletano, il Cardinale tedesco Federico Althann, autore dell’ordine di esecuzione del Galluzzo, secondo alcuni solo per ripicca. Il Cardinale si era già difeso dicendo che i tentativi di salvare l’uomo erano falliti nonostante la buona volontà. L’occasione di rivedere il Cardinale fu propizia al Principe per riempirlo di parolacce sfidandolo a duello. Di tutta risposta il Cardinale minacciò di degradarlo mandandolo su tutte le furie. “Tu non sei degno di fare il Vicerè in casa mia!”, gli disse in faccia e gli si avventò contro per prenderlo a schiaffi. Fu bloccato dai domestici. Il mancato rispetto gli procurò la “partenza forzata” alla fine di quello stesso 1723, mentre il Vicerè annunciava vendetta. La Corte, contraria alle scelte cardinalizie, non mancò di complimentarsi con il Principe, ma il suggerimento di lasciare la città in anticipo rispetto ai viaggi previsti era stato unanime. Doveva evitare la ritorsione del Vicerè. Da qui la partenza in pompa magna, insieme alla moglie, lanciando monete d’argento dalla carrozza per le vie di Napoli.
Ancora una volta, però, i tempi stavano cambiando. Fra il 1732 e il 1735 fu un continua prepararsi alla guerra. Diciamo che questi erano anni difficili ad ogni livello. Signori come Don Marino III Caracciolo dovevano fare i conti con gli intrighi dell’aristocrazia. Gli Spagnoli non vedevano l’ora di riprendersi il Viceregno di Napoli, mentre l’Imperatore Carlo VI non sembrava volersi immischiare se non per mantenere la Lombardia. La guerra, dopo quattro anni di preparativi, venne dichiarata tale il 1 gennaio 1734.
La riconquista sembrava un fatto già scontato ancora prima della partenza, quando Re Filippo e la Regina Elisabetta diedero gran festa nel Palazzo di Madrid. Don Carlos, l’Infante di Spagna, s’inginocchiò davanti al trono ricevendo dal padre il segno della croce sul capo. Quando si rialzò la sua spada fu cinta d’oro e di gemme con poche ma significative parole: “E’ la stessa che Luigi XIV, mio avo, mi pose al fianco quando m’inviò a conquistare questi regni di Spagna: porti a te, senza i lunghi travagli della guerra, fortuna intera”. Il bacio sulla gota fu il segnale. In pochi giorni gli eserciti riunitisi in Francia alla guida del Maresciallo di Villa’s, mossero alla volta dell’Italia per cinque strade. I primi successi furono in Lombardia, poi, con gli sbarchi nei porti di Livorno e Longone, tutto l’esercito si radunò negli Stati di Parma dove, alla guida di Carlo, si diresse in Toscana. Per suo conto o per conto dell’Imperatore sembrava difficile capirlo. In ogni caso era accompagnato nel comando, per il Consiglio, da Conte di Montemar quando si “avviarono nemichevolmente verso Napoli”.1
La scarsa chiarezza politica fu gioviale all’esercito del piccolo Carlo di Borbone. Le casacche aumentavano a vista d’occhio ingrossando le file da destra a manca. Erano soldati provenienti da Firenze, Siena, Arezzo, Perugia.
Quando le truppe spagnole, sbarcate a Livorno, si riunirono con quelle dei generali Montemar e Liria in direzione del Regno di Napoli, le cose stavano cambiando. Il papa avrebbe lasciato passare gli Spagnoli, pronti a ricongiungersi a Don Carlo, nominato Generalissimo dell’armata. Ormai a Vienna importava poco del Regno di Napoli e ancor meno di quello di Sicilia, impegnata com’era a fronteggiare i Francesi per cacciarli dalla Lombardia.
Il Conte di Montesanto, vedendo l’imminente pericolo per Napoli, pregò l’Imperatore per avere dall’armata destinata a Milano almeno cinque reggimenti da affiancare al Generale Carafa e impedire agli Spagnoli l’entrata nei confini. Ma l’Imperatore stette fermo, rispondendogli che non poteva indebolire l’esercito destinato alla Lombardia.
Fra l’11 e il 17 marzo 1734 gli Spagnoli entrarono nello Stato Pontificio sbaragliando gli avversari a San Germano. Il 3 aprile già minacciavano Avellino, dove si era rifugiato Giulio Visconti, l’ultimo Vicerè austriaco del Regno, pronto a partire per le Puglie, in quanto i porti meridionali del litorale tirrenico erano già nelle mani degli Spagnoli. Inutili furono i soccorsi richiesti dai Napoletani. Giunsero in ritardo per i confusi imbarghi di Fiume e Trieste, mentre i Catalani fuoriusciti, i micheletti, dimoravano oziosi a Vienna capeggiati da Rocco Guinart. Al Marchese di Rialp non giungevano neppure le reclute per respingere altri Catalani, quelli dell’Imperatore Carlo, nella speranza di farli disertare qualora avessero incontrato i compatrioti assoldati da Vienna.
Il Marchese di Rialp, dal canto suo, incitava i Napoletani a difendere la città con una lettera, sostendendo il paventato arrivo delle truppe dalla Lombardia: Trattò i Napolitani da stupidi ed insensati, come se non sapessero che gli Spagnoli erano già entro i confini. La speranza era che facessero da spartiacque in prima linea. Ma Napoli non rispose al Marchese, rinfacciandogli i tanti milioni del Regno sperperati per la cassa militare, più volte rifatta per mantenere la custodia dei confini. Ventiduemila soldati ridotti a pochi reggimenti. Ma non solo. Quello che Napoli condannò al Marchese erano i tanti donativi avuti, le sovvenzioni somministrate per le munizioni e le paventate fortificazioni di Castelli e Piazze. Dov’erano le truppe che dovevano giungere dall’Adriatico? L’Imperatore li aveva abbandonati, nonostante avessero riservato fedeltà alla maestà imperiale di Cesare. Nessun perdono, ma compatimento. E qualora fossero stati abbandonati, nell’ultima necessità, avrebbero preso quel partito “che fosse per riuscir loro più salutare, e che apportasse alla Città e Regno tranquillità e riposo”.2
L’esercito spagnolo comandato dal Generale Montemar, tra cavalleria e fanteria, era composto da quattordicimila soldati, accresciuti per strada a diciottomila. Sotto gli auspici del giovane principe Don Carlos, superati i confini, aveva proseguito la marcia senza ostacoli, senza impegnarsi, e a stretto assedio, passarono oltre, proseguendo le conquiste in Terra di Lavoro. Oltrepassato il passo di Mignano, giunse nel mese di aprile ad Aversa dove i deputati napoletani, mentre si stanziava a Maddaloni, gli consegnarono le Chiavi della nuova Capitale. A Capua, invece, si erano ritirate le poche truppe alemanne unendosi a quelle del presidio affinché potessero difendere almeno quella Piazza.
Napoli era ormai vuota, essendo fuggiti il Viceré Conte Visconti, successo al Conte di Harrac, il general Carafa ed altri ufficiali tedeschi, avviatisi con le truppe in Puglia. L’intento era quello di ritirarsi in Calabria in caso di ulteriori perdite, per preservare le province più prossime alla Sicilia.
Gli Spagnoli entrarono in Napoli senza scompiglio. I castelli furono cinti d’assedio. Presto arrivò la resa di Castel S.Ermo e di Castel dell’Ovo, poi di Castelnuovo, facendo i presidi prigionieri di guerra. Dopo Napoli si torsò verso il Garigliano, all’assedio di Gaeta. Una delle sue piazze, fra le più espugnabili, cadde in meno di dieci giorni. Pescara resisté quaranta giorni. Poi caddero definitivamente i due Abruzzi, Terra di Lavoro, le province di Capitanata e Contado di Molise, i Principato Citra ed Ultra.
L’oppressione della Corte austriaca nel Regno di Napoli era terminata. La paura invase i Viennesi. L’Imperatore, nel perdere le maggiori rendite, immaginava imminente la miseria. Imputavano al general Carafa di essere stato vile e codardo nell’aver abbandonato il confine, chiamandolo a render conto della sua condotta, sottraendogli il comando delle truppe alemanne e affidandolo al principe di Belmonte. Così, mentre i rinforzi non arrivarono mai neppure in Puglia, gli Spagnoli furono nelle pianure e fra le macchie di Bitonto, che resero inutile l’opera degli ufficiali della cavalleria tedesca, dichiaratisi in breve prigionieri di guerra.
Il conte di Montemare ebbe campo libero per liberare la Basilicata, la Terra d’Otranto e le due Calabrie. Le truppe del Passo di Mignano sosterranno a lungo l’assedio di Capua, fino ad arrendersi all’onorata condizione, di poter lasciare il Regno imbarcandosi nei porti dell’Adriatico, a patto di non sbarcare a Fiume e Trieste, dov’erano stanziati gli Austriaci impegnati nella guera di Milano.
Ecco come gli Spagnoli di Vienna persero in pochi mesi il Regno di Napoli e, presto, la Sicilia che volontariamente si offrì di ricevere i vascelli quando Lipari inalberò le insegne di Spagna ed unì le sue navi a quelle spagnole.
Ancora una volta il conte Visconti fuggì imbarcandosi alle marine di Bari per Ancona, con l’intento di ricondursi a Vienna. Il Marchese di Rialp però gli scrisse di non ripartire per Trieste e di attendere gli ordini di Sua Maestà “per ciò che conveniva di fare intorno al Regno di Napoli”. Così fece con il Marchese Rubi, nominato Vicerè in Sicilia, una volta rimosso il Conte di Sastago, invitandolo ad attendere ordini di Sua Maestà a Malta. Ora era il Regno di Napoli ad avere due Vicerè: uno risiedeva ad Ancona, l’altro doveva reggere la Sicilia da Malta. Ma non solo. Il conte di Montesanto, da Presidente spodestato, non fece cessare neppure il Consiglio, obbligando i consiglieri, reggenti e segretari, con gli ufficiali di segreteria, “a venir come prima a passar quelle ore nella lettura delle gazzette, ed a discorrere del più e del manco intorno alla guerra presente”.3
Prima del Viceregno austriaco tutto dipendeva dalla Corte di Madrid. Con il ritorno degli Spagnoli si creò un Corte autonoma a Napoli dove Carlo non si era insediato come generalissimo, sebbene all’inizio così firmasse gli editti regi mandati dalla Spagna, nè come Vicario di Re Filippo, ma da Re dei Regni di cui stava per ultimare la conquista. Re Filippo di Spagna, in un dispaccio del 15 maggio del 1734 alla Città di Napoli, complimentandosi per la fedeltà verso l’antico e natural suo signore nel ricevere le sue armi col figlio, lo lasciava per gratitudine come Re. Carlo era il solo a cui dovessero ubbidire in quanto il Regno di Napoli, come quello di Sicilia, si consideravano separati dalla Corona, con propria sede regia in Napoli, da dove il Sovrano li avrebbe retti e governati. I napoletani dovevano sentirsi grati verso Re Filippo, il quale, dopo quasi due secoli e mezzo, li faceva smettere di essere provinciali riacquistando un proprio Re, sebbene a Vienna si credeva fosse solo un’ambizione della Regina madre, “la quale, non contenta di averlo stabilito in Italia, coi Ducati di Parma e di Toscana, un gran principe, volesse ora, colla giunta di due regni, costituirlo un gran Re”.4
Ma poteva essere durabile? La Pace di Vienna del 1725 apparve come il pretesto per staccare i due Regni dalla Corona di Spagna e muovergli poi guerra per recuperarli. Una “semplice” lettera del Re, senza il consenso dei Parlamenti e delle Corti di Spagna, poteva smembrare il Regno e fare un torto al legittimo successore Principe di Asturias? Quando Napoli e la Sicilia erano stati incorporati al regno aragonese, Ferdinando il Cattolico, reputò ingiusta la separazione e, scacciandone Federico, li restituì alla Corona d’Aragona. Poteva una lettera del Re staccare Napoli dalla Corona di Spagna e traformare il Generalissimo Carlo in Sovrano d’un Regno senza armata da due secoli una volta ritornate le truppe in Spagna? Queste domande si poneva Vienna mentre, nei dispacci di Napoli, Carlo si firmava Re e legittimo proprietario del Regno, e le truppe alemanne erano ancora a Capua.5
Alla vigilia della festività di San Pietro Re Carlo pensava di presentare la chinea al Papa con la speranza dell’investitura, sebbene gli mancasse ancora Capua, antica capitale nella storia degli imperatori tedeschi. Ma l’anno successivo, quando il Regno fu liberato completamente, il papa non volle più riceverla neppure da Vienna, in attesa di vedere come andassero a finire i moti d’Italia. Intanto Carlo battè ugualmente moneta d’argento con la scritta Neapolis Rex, senza dirsi VI, VII o VIII Re di Napoli. Senza considerare l’invasione austriaca bisognava che si chiamasse Carlo VI oppure, da Borbone francese, Carlo VII. Ma preferì solo Carlo. Sebbene “non si arrivasse mai a capire che volesse dinotar quel motto, posto nella moneta stessa, sopra il Sebeto”: De Socio Princeps che non poteva riferirsi nè a Napoli, nè ad un nuovo re. Per i Siciliani era invece più facile continuare la dinastia e battere moneta con Carolus III, Siciliae rex. Non avendo avuto l’invasione Angioina non avevano riconosciuto che Carlo II Re di Spagna. E il Principe pensò bene di recarsi in Sicilia per essere incoronato Carlo III a Palermo.6
Così, mentre a Napoli si insediava una nuova Corte con l’onnipresente filopapale Conte di Santo Stefano, la nobiltà continuò a godersi la vita con galà e viaggi. Per il Carnevale del 1735 il Principe della Torella Caracciolo era già a Venezia a rallegrarsi del diverso sistema di fare politica a Napoli.7
9. La complessa elaborazione catastale: Atripalda consegna nel 1755
Riconquistato nel 1734 il Regno, Carlo III, decise di dare un nuovo volto ai suoi possedimenti meridionali. Avvalendosi dell’ausilio di valenti giuristi ed economisti napoletani quali Galiani, Filangeri e Genovesi, nonché della preziosa collaborazione del ministro Tanucci, mise in atto svariate iniziative di grande utilità e di indubbio spessore. Fu avviata una riforma fiscale che avrebbe dovuto rivitalizzare le attività economiche oltre ad assicurare una maggiore giustizia fra i vari ceti sociali, annullando la dannosa sperequazione, fonte di tanti dissidi e sconvolgimenti. Perno di questa attività riformista fu proprio l’istituzione del Catasto Onciario di cui erano obbligate a dotarsi tutte le Università del Regno, in cui, secondo lo Scandone, ogni cittadino era obbligato a presentare la ‘rivela’ di tutte le rendite provenienti da beni immobiliari e mobili e dalla propria attività di lavoro, anche semplicemente manuale. La somma globale veniva calcolata in once per il valore, ognuna, di 6 ducati; somma divisa per il numero complessivo delle once dell’intera Università dando un coefficiente da applicare per calcolare ciò che avrebbe dovuto pagare ogni contribuente moltiplicandolo per le sue once. Analisi complessa, ma dettagliata e precisa, del nuovo sistema impositivo e rivoluzionario, tassando tutti i terreni del Regno nella misura del cinque per cento sul reddito annuo (ovvero tre carlini ad oncia, dedottene le spese di coltivazione), tranne i beni feudali e i terreni appartenenti al patrimonio sacro, secondo il concordato, purché questi ultimi non avessero una rendita inferiore a 24 ducati e non superiore 40, come da allegata rivela.
Va detto che i Signori in un certo senso si ritrovarono avvantaggiati in quanto la casa adibita a propria abitazione era immune da balzelli, mentre si tassava il reddito del fitto, detratte le spese di manutenzione. Gli animali posseduti che formavano l’oncia d’industria erano tassati al 10 per cento, tranne gli animali ad instructionem feudi perché facevano parte dei beni feudali.
Dei capifamiglia si tassarono il denaro prestato e i censi attivi. Oltre i beni posseduti, dovevano versare il testatico, 1 ducato su ogni singola testa, e la tassa sull’industria o arte che esercitavano: gli speziali ed i procuratori erano tassati per once 16; i suonatori, massari, cucitori, calzolai, barbieri e bottegai per once 14; vatecali, potatori, ortolani e bracciali per once 12. Le once d’industria dovevano essere pagate anche dai lavoratori compresi nella fascia di età tra i 14 ed i 18 anni in ragione della metà.
Non pagava tassa, come detto, chi viveva nobilmente, o con la rendita dei propri averi, e chi esercitava una professione nobile, ovvero medici, dottori di legge, giudici e notai. E non pagavano i 10 carlini neppure i sessagenari, i minori di 18 anni.
Nel caso l’Università comunale non riusciva a raggiungere la cifra dovuta al fiscoda tutti gli abitanti, dovendosi aumentare la tassa della testa, gli esenti, eccetto i minori di 18 anni che de jure non sono sottoposti al pagamento di testa in qualsivoglia somma venga la medesima tassata, dovevano contribuire pagando la quota eccedente i 10 carlini. Non erano tenute a pagare il testatico e la tassa del mestiere neppure le donne. Le persone che pagavano le tasse erano suddivise in: forestieri bonatenenti che sborsavano 42 carlini a fuoco per quanti erano i fuochi dell’Università; forestieri abitanti che, oltre ai fuochi, dovevano lo jus habitationis di 15 carlini, più spese comunitative; cittadini dell’Università, i quali dovevano contribuire a coprire tutti i pesi che essa sopportava.
Il clero era stato diviso in ecclesiastici in minoribus ed ecclesiastici ascesi agli ordini sacri: i primi dovevano pagare per i beni posseduti a seconda della categoria di appartenenza (forestieri bonatenenti, forestieri abitanti o cittadini), ma non pagavano il testatico e la tassa delle once d’industria; i secondi erano tassati solamente per l’eccedenza del patrimonio sacro. I beni appartenenti ai luoghi pii, secondo il concordato, erano tassati per la metà, se i beni erano stati acquistati prima del concordato, o per intero, se erano stati acquistati dopo. Non erano soggetti a tassa i beni di seminari, parrocchie e ospedali.
Vi erano poi delle persone che godevano di alcuni privilegi che davano diritto ad una esenzione totale o parziale (cittadini napoletani, padri onusti di dodici figli, gli abitanti di Cava).
La formazione del Catasto Onciario, dunque, si presenta elaborata e complessa, sebbene le Prammatiche emanate dalla Regia Camera, a cominciare dalla Prammatica I del 17 marzo del 1741 che riguarda gli atti preliminari a farsi spettanti alle Università, annunciavano un lavoro semplice da farsi con atti, apprezzi e rivele che, una volta portati a termine, dovevano essere inviati all’autorità centrale a cui spettava la formazione dell’Onciario, cioè la determinazione del censo da pagare. Ma i rallentamenti giunsero uno dopo l’altro per i più svariati motivi, fin dall’inizio. Lo stesso Re Carlo III, nel mese di giugno dello stesso anno, in nome della sua lotta contro il potere ecclesiastico, raggiunto il Concordato con la S.Sede, investì la Regia Camera per integrare le prime istruzioni con nuove disposizioni, gli Avvertimenti, giungendo al 23 di agosto, quando finalmente si stabilì di inviare a tutte le Università del Regno l’ordine di immediata esecuzione delle stesse ed in più si decretò di affidare il compito alle stesse Università per la formazione dell’onciario. E questo fu un altro errore, sebbene lo spirito fosse proprio quello di affidare la compilazione a dei deputati locali, i quali, grazie alla conoscenza diretta, avrebbero permesso di velocizzare le cose, finendo invece nella inattesa direzione opposta.
Una decisione molto criticata da giuristi ed economisti in quanto, rimettendo il tutto ad una commissione eletta dal Parlamento cittadino, veniva a mancare l’obiettività reale dell’operazione. Queste seconde istruzioni furono inviate alle Università il 28 settembre del 1742, concedendo quattro mesi di tempo per il completamento delle operazioni. A questo va aggiunto il tempo necessario alla massima attenzione da prestare sui calcoli: ogni librone dell’onciario andava redatto in doppio esemplare, uno destinato alla stessa Università, l’altro, corredato da tutti gli annessi (preliminari, apprezzo, rivele, atti), doveva essere inviato al grande Archivio della Camera della Sommaria di Napoli.
Negli Onciari si possono scovare curiosità che accomunano perfino i centri abitati più lontani. Per esempio nel Catasto di Alessandria del Carretto del 1742, denominato Catasto Onciario di Alessandria di Calabria Citra, vi scopriamo il magnifico Pasquale Chidichimo che faceva il bandieraro, cioè l’alfiere del Battaglione a piedi della Città di Avellino.
Per Atripalda é possibile scoprire l’affermarsi dei primi maestri d’arte, che si distinguono da braccianti e vaticali, che cominciano a possedere nuove case sebbene non arrivano al possessore che vive del suo nella Casa palaziata, a beffa di chi possiede solo una casa, cioè una stanza.
Nel Catasto é quindi possibile riscontrare i nomi di tutti i cittadini dell’epoca, finanche delle vedove e delle vergini in capillis (fanciulle da matrimonio), degli ecclesiastici, dei forestieri abitanti e non, e di tutte le altre presenze, oltre l’effettivo contributo in denaro pagato allo stato per il possesso dei beni e per i servizi (macellazioni, vendite al dettaglio, etc).
Il Catasto di Atripalda, come pochi altri del Principato Ultra, é stato riprodotto su nastro fotografico e si conserva in maniera egregia presso l’Archivio di Napoli, benchè copia di esso doveva esistere anche presso il rispettivo Comune. Gli originali delle Università finirono presso l’Archivio di Stato di Napoli perchè erano in possesso della Regia Camera della Sommaria (da dove pervennero), ufficio del Regno incaricato a partire dal 1741 alla riscossione diretta delle tasse. Altre informazioni si ricavano sui componenti dei nuclei familiari, indicandosi il numero, la loro età, l’attività svolta ed il rapporto di parentela con il capofamiglia. Curiosità che aiutano a capire la vita condotta ad Atripalda mentre veniva redatto questo grande inventario (che resterà in vita fino ad essere sostituito da quello napoleonico imposto con la dominazione francese dopo il 1806) consegnato 13 anni dopo l’entrata in vigore della legge.
Per i grandi nuclei del Regno ci fu necessità di dividerli in quartieri in quanto le schede occupavano diversi volumi, per quelli piccoli come Atripalda bastò un solo volume, sebbene consegnato oltre dieci anni dopo l’entrata in vigore della legge, nel 1755.
In questi anni ogni paese é davvero uno stato a se. Sarà sempre meglio quindi distinguere prima la Chiesa parrocchiale, così come accaduto per altri luoghi, seguita dalle secondarie e dalle cappelle laicali delle congregazioni. Ma il potere resta in mano ai parroci, i quali, da secoli registravano i cittadini, fra libri di nati, morti, matrimoni, etc. Ed anche per il Catasto, stavolta in collaborazione con il parroco, ma in forma civile, ogni residente é addirittura obbligato a dichiarare i beni posseduti, come si legge negli atti preliminari, dov’è allegato il singolo atto di fede di ogni cittadino, cioè l’impegno scritto, a cui spesso si rimanda, giusta la fede, quella degli atti preliminari. Ed é partendo da queste dichiarazioni, cioè dalle rivele effettuate dai cittadini (quasi sempre spontanee), che le commissioni poterono redigere i catasti in tempi brevi per l’epoca, benchè in alcuni casi furono terminati dopo molti anni. Proprio come nel caso di Montemiletto la consegna avvenne nel 1755 per un tomo che, al contrario di città come Caserta, non ebbe bisogno neppure delle sezioni dei volumi catastali denominate Repertori, in quantofu diviso in semplici sezioni.
L’Onciario del nostro comune fu denominato Catasto Onciario d’Atripalda in Principato Ultra – anno 1755 fatto rientrare nel Distretto di Avellino. A seguire, già dalla prima pagina, cominciano i nomi dei capifamiglia. Prima però di sfogliare questa sorta di albero genealogico degli atripaldesi, ci é parso opportuno, rispolverare un po’ di storia, nuda e cruda, sulle istituzioni religiose….







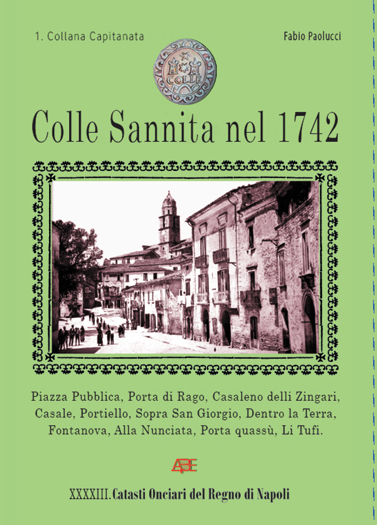






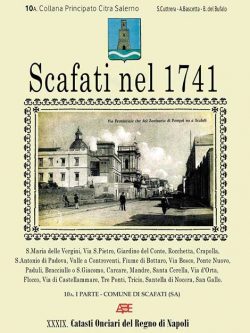

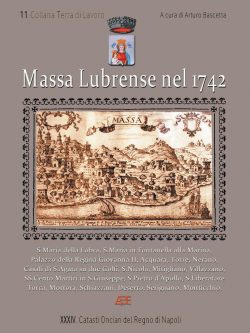
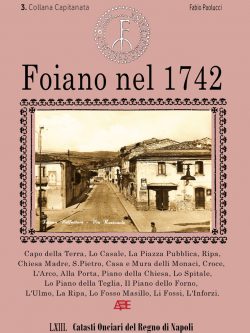
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.